Parla Claudio Risé: «Una società che sradica l’autorità
paterna produce disagio e dipendenza».
(Intervista a Claudio Risé, di Riccardo Paradisi, da
“L’Indipendente”, 18 marzo 2007)
Domani è la festa del papà: migliaia di uomini divorziati
chiederanno il diritto all’affido dei propri figli che l’attuale
giurisdizione nega per principio.
Domani 19 marzo è la festa del papà: migliaia di padri
divorziati in Italia hanno scelto questa data come occasione per
rivendicare ogni anno il diritto all’affido dei propri figli. Un
diritto che è praticamente loro negato da una giurisdizione che
nella quasi totalità dei casi affida automaticamente alle madri
la tutela dei figli.
Una settimana fa, invece, a Roma si è tenuta una manifestazione
che tra gli obiettivi aveva la contestazione dell’ordine
simbolico della famiglia patriarcale. Una realtà che in
Occidente ha smesso di esistere da almeno tre decenni.
Claudio Risé – psicoanalista, scrittore, autore di saggi
fondamentali sulla paternità (tra gli altri
Il mestiere di padre e
Il Padre, l’assente inaccettabile, edizioni
San Paolo), è impegnato da anni in un lavoro di denuncia sulla
scomparsa dell’ordine simbolico paterno. Il padre, dice Risé, è
il grande assente del nostro tempo. E questa assenza fa male. A
questa assenza si deve porre rimedio.
Quando comincia, prof. Risé, l’eclisse del padre?
Inizia con la critica radicale e militante della ragione
illuminista all’ordine simbolico paterno che aveva garantito
ritmo e forma alla psicologia occidentale, in sinergia con
l’ordine simbolico materno, che presiedeva ad altri scopi e
funzioni. È con lo sviluppo di questa critica che il padre
comincia ad assumere nella società un ruolo puramente
funzionale. Diventa produttore di ricchezze, rifornitore di
alimenti, homo oeconomicus, insomma. Semplice pedina di
un meccanismo che ha regole razionali miopi e che decide di
poter fare a meno di un sapere simbolico, della necessità dei
riti di passaggio, dell’esperienza dell’identità di genere.
Il padre è in fabbrica, in guerra o in azienda. A educare i
figli ci pensano solo le donne. E lo Stato. La società si ispira
a principi sempre più chiaramente, ed unilateralmente, materni.
Ma non funziona.
Perché non funziona?
I frutti di questo processo possiamo coglierli oggi. La società
dell’assenza del padre è quella dell’assenza della norma morale
sostituita dalla moltiplicazione dei dispositivi giudiziari e
dei regolamenti burocratici: che però non riescono nemmeno ad
arginare il disorientamento, il disagio profondo che genera una
realtà da cui l’archetipo del padre è rimosso, o ridicolizzato o
addirittura criminalizzato.
Attribuendo al materno oneri e responsabilità che non gli
competono, e per le quali non ha vocazione.
Lei ha scritto che la società senza padre è una
società patogena. Entrando nel merito in cosa si manifesta
questa patologia?
Le statistiche purtroppo parlano chiaro. Secondo i dati forniti
in questi anni dagli uffici di censimento americani – e gli Usa
sono un esempio significativo visto che stiamo parlando del
Paese che è il pesce pilota dell’Occidente – il 90 per cento di
tutti gli homeless, persone senza dimora, e dei figli fuggiti da
casa, non avevano un padre in famiglia. Il 70 per cento dei
giovani delinquenti ospitati in istituzioni statali venivano da
famiglie dove non c’era il padre. L’85 per cento dei giovani che
si trovano in carcere sono cresciuti senza padri. Il 63 per
cento dei giovani che si tolgono la vita hanno padri assenti.
Perché questa relazione tra devianza e assenza del
padre?
Perché il padre è autorevole in quanto dà la forma, quindi la
norma, il limite, il confine. Senza il padre siamo nella
“società liquida”, informe, così ben descritta da Zygmunt
Baumann. È il padre che ha il compito di strappare il bambino
dalla totalità fusionale con il mondo materno per trasformarlo
in un adulto, per iniziarlo alla vita e alle sue prove: alle
lotte, alle sconfitte e alle esperienze di separazione che la
vita inevitabilmente riserva.
Se questo lavoro non viene fatto accade quanto abbiamo sotto i
nostri occhi: i cittadini della società senza padre vedono la
perdita come un affronto personale più che come una prova
dell’esistenza, legata anche al destino personale
dell’individuo.
Nel rifiuto dell’autorità c’è anche questo rifiuto
del limite, dunque?
Dover riconoscere il principio di autorità che ti aiuta a
riconoscere la tua propria forma è un sacrificio del proprio io,
della dittatura del principio di piacere. L’incapacità di fare
questo sacrificio porta a vivere ogni autorità come un sopruso.
Anche in quei casi dove si è di fronte ad un’autorità reale e
non a un semplice arbitrio concesso dal potere e dal privilegio.
Adeguarsi alla norma, reggere il confronto con la realtà,
diventa quindi molto difficile senza un padre che introduca alla
società.
È per questo che i figli senza padri capeggiano le
statistiche dei suicidi? Con il 75 per cento?
Sì, è anche per questo, ed è per lo stesso motivo che si assiste
al continuo rinvio dell’età in cui si esce dalla casa dei
genitori o alla moltiplicazione di disagi, compresa la
difficoltà a riprodursi che interessa ormai circa il 40 per
cento dei maschi bianchi. Sono tutti sintomi che illustrano la
progressiva passività dello stile di vita in Occidente. Un
risultato del suo trasferimento sotto la guida del principio,
tutto femminile – materno, della soddisfazione del bisogno.
La cultura del narcisismo e dello spettacolo, e gli
aspetti più esasperati del consumismo, sono dunque espressioni
della negazione della paternità?
Sono l’espressione del suo archetipo antagonista: quello della
Grande Madre onnipotente (che non accetta di dividere il suo
potere con il principio paterno). Essa non è una madre buona,
anzi.
L’attuale società dei consumi che tratta l’individuo
esclusivamente come consumatore è l’espressione più compiuta del
potere dispiegato dalla grande madre che viene appunto
conservato mantenendo l’individuo nella sua dimensione
infantile: di soddisfacimento del bisogno ed evitandogli
l’esperienza del limite, della separazione. Che quando avviene è
appunto vissuta come tensione e mutilazione insostenibile.
La settimana scorsa migliaia di persone hanno
manifestato nel centro di Roma per chiedere al governo
l’approvazione della legge sui Dico. Lei che cosa pensa di
questa legge?
La ritengo diseducativa e deresponsabilizzante. Fortemente
lesiva sul piano della crescita del senso della responsabilità
personale: si vuole imprimere un sigillo giuridico a un legame
affettivo temporaneo e disimpegnato.
Ma il rumore che si fa intorno ai Dico non è proporzionato alla
reale entità del problema. Come ho già ricordato in un’altra
occasione i cosiddetti registri per le unioni civili che sono
sorti in varie città italiane hanno fatto registrare scarsissime
adesioni. E questo perché in Italia ci sono sufficienti
disposizioni legislative per chi intende unirsi e impegnarsi in
un matrimonio. Sia con il rito religioso sia con quello civile.
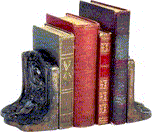 www.segnalo.it -
Politica dei servizi sociali - Saggi e Articoli
www.segnalo.it -
Politica dei servizi sociali - Saggi e Articoli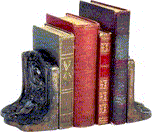 www.segnalo.it -
Politica dei servizi sociali - Saggi e Articoli
www.segnalo.it -
Politica dei servizi sociali - Saggi e Articoli